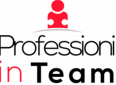Se Elly Schlein ne andasse senza che nessuno la vedesse andar via, ci resterebbe anche il dubbio che sia mai esistita.
Tra moderati inquieti, sinistre coalizzate e un centro che non decolla, la segretaria dem entra nella fase più delicata: vuole guidare l’intera coalizione, ma rischia di restare leader solo di una parte.
In evidenza

Il “caso Garofani” è solo l’ultima spia di un malessere che nel Pd covava da mesi: la frattura mai sanata tra l’asse riformista di matrice ex democristiana e il nuovo gruppo dirigente plasmato da Elly Schlein. Garofani non parla solo per sé, e infatti le sue parole somigliano a quelle pronunciate o sussurrate da Prodi, Gentiloni, Zanda, Castagnetti. È il risveglio di un mondo che si era illuso che la vittoria congressuale di Schlein sarebbe stata un passaggio temporaneo, non una rifondazione identitaria.
Schlein reagisce a modo suo: trasforma l’episodio nel “lodo Zanicchi”, una narrazione autoassolutoria secondo cui anche la destra pop all’occorrenza la troverebbe votabile. È un antidoto retorico utile per galvanizzare la base, ma non risolve il nodo vero: i moderati del Pd non si riconoscono nella sua leadership, e non sentono garantita una rappresentanza politica che sia più larga del recinto progressista.
Nel frattempo, la segretaria si abbraccia con le correnti di sinistra e i franceschiniani a Montepulciano, compattando un blocco che diventa, nei fatti, il nuovo baricentro del partito. È una scelta tattica che rafforza la maggioranza interna ma indebolisce la vocazione pluralista del Pd, proprio mentre dovrebbe costruire una coalizione capace di parlare al 45% del Paese.
I riformisti reagiscono con un controvertice a Prato: un gesto simbolico ma eloquente. Non hanno la forza numerica per sfidare Schlein in un congresso, ma hanno la forza politica per rendere complicata la costruzione delle liste e della futura coalizione. Schlein lo sa: la loro “debolezza” è relativa, perché nella partita nazionale i voti moderati valgono più dei numeri congressuali.
Resta lo scenario delle primarie di coalizione. La segretaria le vuole; gli altri, più che volerle, le temono. Conte è l’unico sfidante reale, e D’Alimonte ha ragione: né una leadership schleiniana né una contiana garantirebbe lo spostamento dell’intero pacchetto di voti del centrosinistra. Ciascuno attrae pezzi diversi, e perde pezzi diversi.
È qui che torna l’antica fantasia del “papa straniero”: una figura esterna, riformista e inclusiva, che permetta a Pd e M5s di evitare la reciproca dispersione di consensi. È un’ipotesi che nessuno ammette apertamente, ma che serpeggia nei commenti dei riformisti, negli appunti del Quirinale e nelle analisi degli accademici. Schlein può battere Conte; Conte può battere Schlein; ma entrambi rischiano di non battere la destra.
In definitiva, l’articolo racconta un partito che si muove molto, ma discute poco. E che rischia di arrivare alla vigilia delle elezioni con una leader forte nel partito, ma non necessariamente nel Paese. Schlein è pronta a correre: ma non è detto che tutti corrano con lei.
Altre Notizie della sezione

Giustizia e politica devono fermarsi, ricostruire fiducia e rispetto istituzionale.
30 Gennaio 2026Alla Cassazione appello corale: stop allo scontro, dialogo leale tra poteri per salvare indipendenza magistratura e credibilità democratica del Paese.

La democrazia è in evidente crisi
29 Gennaio 2026Sotto attacco al suo stesso interno perché ritenuta incapace di fornire risposte ai bisogni delle persone e soprattutto alle paure.

Referendum giustizia, una sfida riaperta?
28 Gennaio 2026Conoscere di più il quesito cambia gli equilibri: il No cresce, il Sì arretra, decisiva sarà la mobilitazione finale