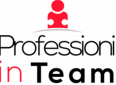La paura (infondata) dell’eutanasia di Stato per far quadrare i conti
Molti temono che lo Stato onnipotente usi l’aiuto al suicidio per risparmiare sulla previdenza e la spesa sanitaria.
In evidenza

Un excursus storico e filosofico per capire che degli Stati pienamente liberali ci si può fidare.
Chi è contro la legalizzazione dell’aiuto a morire sostiene che chi la difende usa un argomento retorico detto della Motta Castrense (dal nome di una tipica costruzione medievale): quando un’affermazione viene sfidata seriamente, ci si ritira su una posizione più difendibile. Se la critica alla legalizzazione tira in ballo il rischio di una deriva verso un’eutanasia involontaria amministrata dallo Stato, ci si ritira sulla difesa dei diritti individuali e della dignità, più facile da far capire, per evitare di prendere in esame il merito della contestazione, e adattare nel mentre il proprio argomento. L’argomento della Motta Castrense è spesso usato nei dibattiti e nelle discussioni, soprattutto dai politici o quando ci si confronta su temi controversi (es. ogm, gravidanza per altri, etc.), per mantenere un vantaggio senza dover giustificare l’affermazione contestata. In realtà, si tratta di una fallacia, perché dà per scontato che chi attacca abbia ragione, quando invece può avere torto più di chi difende.
La giornalista inglese, Louise Perry, ha pubblicato una opinion sul New York Times dove sostiene che la legalizzazione dell’aiuto a morire prefigura una dimensione economicamente perversa. I punti di partenza sono il progetto di legalizzare il suicidio assistito in Inghilterra e Galles, e la constatazione che tutte le giurisdizioni che hanno legalizzato o stanno legalizzando il suicidio assistito hanno un tasso di fertilità totale inferiore alla soglia di sostituzione. Con acume argomentativo si aggancia al famoso romanzo del 1993 di Phyllis Dorothy James, I figli degli uomini (vedi anche film del 2006), dove si immagina una crisi demografica che induce i governi a facilitare il suicidio degli anziani attraverso un rituale noto come “il Quietus” – il governo adotta strategie autoritarie mascherate da benevolenza e burocratizzate perché anziani e malati si sentano inutili, quindi si suggerisce come via d’uscita dalla disperazione, una scelta compassionevole e apparentemente ragionevole, che consiste nell’eutanasia “volontaria”. La fantascienza è sempre un terreno formidabile per le discussioni etiche, più interessante e profondo dei testi filosofici o teologici
Perry ritiene che lo scenario demografico in arrivo rappresenti una minaccia esistenziale soprattutto per i sistemi di welfare, che dipendono dai giovani lavoratori per finanziare i diritti e l’assistenza sanitaria degli anziani. Chi crede che politiche liberali in materia di immigrazione risolveranno questo problema non terrebbero conto che anche gli immigrati invecchiano e che i loro tassi di natalità di regola convergono con quelli della popolazione di destinazione, nel corso del tempo. La giornalista prevede che si tornerà con gli anziani assistiti in casa da figli e nipoti o da enti di beneficenza. Insomma, un carico economicamente e socialmente sempre più insostenibile.
Chi è favorevole alla legalizzazione, dice Perry, sta usando l’argomento della motta castrense per eludere la discussione di un problema che assumerà dimensioni epocali. Nondimeno, chi, come lei, cerca prove di questi rischi si richiama al fatto che in alcuni paesi i sistemi sanitari aiutano le persone a terminare la vita e in alcuni casi le persone autorizzate non sono terminali in senso fisico, ma per esempio soffrono di malattie mentali. Questo punto è sempre delicato, ma chi ne parla sembra credere che i disturbi mentali siano meno dolorosi di un tumore o di gravi malattie polmonari: niente di più falso. Nelle depressioni gravi o nei disturbi bipolari resistenti ai trattamenti, neppure la morfina è utilizzabile per lenite intollerabili sofferenze emotive. Poi ci sono i casi di malati con disturbi neurologici o gravi malattie metaboliche che hanno chiesto l’aiuto a morire, in quanto percepivano la minaccia del sistema sanitario e delle assicurazioni di lasciarli senza cure a causa dei costi (in Canada). Si tratta, per il momento, di aneddoti.
Il problema, come dice Perry, è se lo Stato onnipotente, ma ancora un po’ liberale, decidesse di non fermarsi più a proteggere le persone da rischi di abusi e discriminazioni, e si mostrasse interessato a raddrizzare il bilancio economico, sul piano previdenziale: non ci sono dubbi che sul lungo periodo l’aiuto al suicidio farà risparmiare molto ai sistemi sanitari. Lasciando da parte l’irritante antropomorfizzazione dello Stato, se le parole hanno ancora un senso, uno Stato liberale che diventa paternalista o nega la libertà individuale, non è più tale. Per definizione l’eutanasia non può diventare involontaria (indotta o obbligatoria), secondo qualche norma legale in una società aperta. Serve una deriva socioculturale e politica, del tutto possibile. Ovvero, l’aiuto a morire può far parte, in modo positivo, e come parte delle cure mediche, di un sistema liberale se è fondato sulla valorizzazione di autonomia, compassione, dignità personale (non religiosa o sociale), razionalità e, in futuro, un’etica tecnologica sviluppata da società avanzate che offrono l’eutanasia come opzione umana, non come punizione.
Le società aperte non sono numerose e la loro capacità di mantenere il pluralismo e rinnovare la libertà individuale è del tutto precaria. Perché i pericolosi miraggi dell’autoritarismo o dello stato etico si presentano a ogni occasione. Nella storia, l’aiuto al suicidio involontario o indotto è stato teorizzato già dal totalitario Platone. Nella Repubblica descrive una società giusta e basata sul valore della vita in relazione alla virtù e al bene comune, per cui il nostro sostiene che le vite prive di virtù o piene di sofferenza non sarebbero degne di essere vissute in senso significativo. L’eutanasia, in funzione di una visione collettivista (bene comune), religiosa e utilitarista, si trova descritta nell’Utopia di Thomas More, pubblicata nel 1516. Circa un secolo dopo (1624) Francis Bacon, formidabile filosofo ma non meno magistrato, scriveva Nuova Atlantide lanciando l’idea che la ricerca scientifica della conoscenza e della comprensione contribuisca a prendere decisioni informate sulle scelte di vita, comprese quelle riguardanti la morte. La sua riflessione era molto attuale e ricorreva a prove empiriche e al pensiero razionale, incoraggiando un esame critico delle implicazioni etiche dell’eutanasia, in particolare riguardo alla qualità della vita e al sollievo dalla sofferenza.
La medicina continuava però a ispirarsi, anche opportunamente va detto data l’ignoranza nella quale barcollava, al cosiddetto Giuramento Ippocratico, che vietava agli adepti della antica congrega di aiutare le persone a morire; un impegno morale che per convenienza e funzionalità, cioè per il fatto che era un veicolo efficace per trasferire nella medicina la teoria cristiana della vita come dono divino indisponibile, era stato adottato dal cristianesimo a fondamento dell’etica medica. La nascita e gli sviluppi della medicina fondata sulla scienza, nella seconda metà dell’Ottocento, producevano nuovi punti di vista ispirati al positivismo medico che aprivano una rinnovata discussione sull’eutanasia. Nel frattempo, un filosofo influente come Friedrich Nietzsche cominciava a lanciare sassi in piccionaia: radicali critiche all’idea cristiana di una vita terrena vissuta con autenticità e ispirata da una moralità schiava della debolezza e del risentimento; quindi, discuteva il valore della vita e le implicazioni di vivere una vita come priva di dignità. Nietzsche non esalta la morte, ma in Così parlò Zarathustra parla e esprime il concetto che quando una vita non è più degna di essere vissuta, il suicidio può rappresentare un ultimo atto di autonomia.
I casi crescenti di malati osservabili in condizioni disperate e che chiedevano una morte “pietosa” a causa delle sofferenze videro emergere l’espressione “vite non degne di essere vissute”, che continua a riecheggiare in senso negativo ma anche positivo nella discussione bioetica. Nel 1920 furono Karl Binding e Alfred Hoche, un giurista e un neurologo-psichiatra, su posizioni positiviste, utilitariste e autoritarie, un libro intitolato Il permesso di uccidere vite non degne di essere vissute, che sosteneva la liceità dell’eutanasia per gli individui ritenuti non degni di vivere a causa di gravi disabilità o malattie mentali. Il testo fu usato dagli ideologi e medici nazisti per portare avanti le strategie di eliminazione statale di malati, anziani, ritardati, e quindi allargando l’applicazione della tecnologia della morte a ebrei, zingari ed etnie “inferiori”, omosessuali, avversari politici, etc.
Il tema dell’eutanasia entrò in sonno o fu usato come tabù dai bioeticisti per alcuni decenni, fino a quando gli olandesi lo riportarono lentamente all’attenzione della pratica medica e dell’etica politica. Per arrivare agli ultimi vent’anni di cui quasi tutti sanno quasi tutto di quel che successe ai quattro angoli del pianeta. Al momento non esiste comunque alcun indizio storico, lontano o vicino (anche se la storia da sola non porta mai prove d’alcun genere), che nei sistemi politici liberali, che rimangono tali, l’aiuto al suicidio possa automaticamente evolvere in una pratica di pulizia di anziani e malati per scopi perversamente economici.
Nel merito specifico della questione eutanasia o aiuto a morire, Bacone scriveva in un testo che precede di un anno la pubblicazione di Nuova Atlantide, intitolato, Historia vitae et mortis, che “il compito del medico non è solo quello di ripristinare la salute, ma anche di alleviare il dolore e le sofferenze; e non solo quando tale alleviamento può portare alla guarigione, ma anche quando può servire a rendere il passaggio equo e facile”. Son trascorsi quattro secoli, ma un concetto tanto elementare, ovviamente adattato al contesto di una società complessa ma anche più sicura come la nostra, non fa breccia tra i medici. Malgrado i tre quarti dei loro pazienti (tra il 65 e l’85% dei cittadini) nel mondo, siano arrivati da soli a capirlo.
Altre Notizie della sezione

Il tempo degli Sciamani. Addio politica, la campagna referendaria si gioca nella tribù
06 Febbraio 2026Non si era mai vista una contesa tanto deprimente: votare No per battere i fascisti, votare Sì per mettere in riga i magistrati. Da Meloni a Schlein, da Bettini a Nordio: a sinistra e a destra trionfano i repertori più usurati.

Qualcosa da correggere.
05 Febbraio 2026Il Quirinale rimette il pacchetto sicurezza dentro la Costituzione Ricondurre le norme nel perimetro della Costituzione. Senza stravolgere l’impianto del pacchetto sicurezza, che il governo resta intenzionato a varare nel

Servono misure per depotenziare i violenti
04 Febbraio 2026Piantedosi: Gli antagonisti hanno coperture politiche.