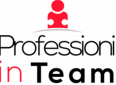La piazza che sceglie le sue vittime
Si protesta solo contro l’Occidente, mai contro chi calpesta la libertà altrove. L’indignazione a senso unico non è giustizia, è ipocrisia.

C’è qualcosa di profondamente sbagliato nella piazza contemporanea. Non parlo del diritto a manifestare, che è sacrosanto, né del desiderio di partecipazione civica. Parlo della selettività morale, di quella capacità sorprendente che ha la coscienza collettiva di indignarsi solo quando conviene, e di ignorare deliberatamente l’ingiustizia quando minaccia la propria idea di mondo. In altre parole: le piazze scelgono le loro vittime, e la logica di questa scelta è spesso sorprendentemente coerente con schemi culturali e ideologici consolidati, più che con il senso universale di giustizia o di umanità.
Non è un fenomeno nuovo. La storia recente dell’attivismo politico e delle manifestazioni pubbliche mostra pattern inquietanti. Guerre devastanti, invasioni e violenze atroci che colpiscono popoli lontani suscitano raramente la stessa indignazione spontanea che si manifesta quando l’Occidente è implicato. Si protesta contro i potenti, contro i forti, contro chi appare come dominante o minaccioso rispetto a schemi consolidati di valori politici e culturali. Se si prova a osservare la geografia delle manifestazioni, si nota un fatto che non può essere ignorato: le piazze si riempiono quando la violenza colpisce l’Occidente o i suoi alleati, mentre restano spaventosamente silenziose quando la vittima è un paese o una popolazione lontana e culturalmente percepita come “altro”.
Questo non significa che l’individuo non possa provare empatia o indignazione genuina. Certamente, molti cittadini scendono in piazza mossi da convinzioni sincere, dalla compassione per chi soffre. Ma la massa, quella che riempie le strade e fa notizia, non si muove mai senza una spinta organizzativa e culturale. Sindacati, partiti, associazioni, media: tutti contribuiscono a costruire un’interpretazione della realtà che seleziona quali violenze meritano attenzione e quali possono essere ignorate. È una costruzione potente e spesso invisibile, perché si nasconde sotto la maschera della spontaneità.
La selettività morale delle piazze è anche un riflesso culturale profondo. In occidente, e in particolare in alcune correnti politiche e sociali, l’Occidente stesso è spesso visto con sospetto. Un antico anti-occidentalismo culturale, sedimentato nel tempo, fa sì che denunciare le ingiustizie contro l’Occidente provochi fastidio o imbarazzo. E così, quando la violenza colpisce l’Occidente o i suoi alleati, la piazza è riluttante a mobilitarsi, mentre quando l’Occidente è percepito come aggressore, l’indignazione diventa immediata e virale.
Questo crea un paradosso morale: è possibile difendere i diritti umani, la democrazia e la libertà di tutti, ma solo fino a quando la difesa non coinvolge chi è culturalmente vicino, o chi rappresenta il proprio schema di valori. Difendere la libertà in astratto è semplice; difenderla quando implica un allineamento con l’Occidente richiede coraggio morale. Pochi sono disposti a sostenerlo. E così l’indignazione diventa selettiva, il giudizio morale a senso unico.
Le conseguenze sono visibili e preoccupanti. La piazza perde credibilità, diventa strumento di conferma di schemi ideologici più che di denuncia di ingiustizie universali. L’indignazione a senso unico genera ipocrisia, e l’ipocrisia mina la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni democratiche. Quando una società osserva la sofferenza altrui con un occhio chiuso, educa i cittadini a chiudere gli occhi anche di fronte alle proprie responsabilità. La piazza smette di essere luogo di giustizia e diventa teatro di conferma identitaria: chi protesta non lo fa solo per la vittima, ma anche per ribadire il proprio schema di valori, spesso inconsapevolmente.
Questo non significa che tutte le manifestazioni siano inutili o false. Significa che dobbiamo riconoscere la costruzione culturale e politica dell’indignazione. Significa che dobbiamo insegnare, come società, a sviluppare una moralità coerente, non selettiva, e a interrogarsi sulle ragioni profonde per cui certe ingiustizie suscitano clamore e altre no. Solo così la piazza può tornare a essere autentica, credibile, degna di rispetto.
Il compito non è facile. Richiede consapevolezza critica, disciplina intellettuale e coraggio morale. Richiede di affrontare l’inconscio collettivo: quella predisposizione culturale a sospettare dell’Occidente, a indulgere con chi è percepito come “altro”, a considerare l’ingiustizia più tollerabile quando colpisce chi non è culturalmente vicino. Combattere questa inclinazione non è solo un esercizio etico, è un esercizio politico e sociale: la coerenza morale rafforza la democrazia e la fiducia reciproca.
La storia e l’attualità forniscono esempi continui. Guerre dimenticate, violenze ignorate, genocidi che non raggiungono le prime pagine dei media mainstream: tutti segnano l’indifferenza selettiva della piazza. Ma anche i successi: manifestazioni autentiche, solidali, universali, mostrano che un’alternativa è possibile. Dove l’indignazione è coerente e la protesta inclusiva, la piazza diventa simbolo di civiltà, di umanità, di giustizia. Questo è il modello da perseguire.
In definitiva, il problema non è il diritto a manifestare, né l’energia civica dei cittadini. Il problema è la coerenza morale, la capacità di indignarsi con giustizia e senza selettività. La piazza deve smettere di scegliere le vittime secondo schemi culturali o ideologici e iniziare a difendere i valori universali: dignità, libertà, rispetto per la vita umana. Solo così potremo parlare di autentica giustizia sociale.
Ecco perché il titolo del nostro editoriale non è casuale: La piazza che sceglie le sue vittime. È una condanna, severa ma civile, dell’ipocrisia morale. Il catenaccio lo chiarisce: Si protesta solo contro l’Occidente, mai contro chi calpesta la libertà altrove. L’indignazione a senso unico non è giustizia, è ipocrisia. È un richiamo alla riflessione, alla responsabilità collettiva, al coraggio di guardare oltre il proprio schema ideologico. È un invito a trasformare la protesta in coerenza morale, e la piazza in luogo di vera giustizia.
Solo quando la società accetterà questa sfida, la piazza potrà tornare ad essere quel luogo di partecipazione, indignazione e speranza che dovrebbe essere, e non un teatro di ipocrisia. Solo allora la voce dei cittadini potrà essere ascoltata come autentica, e non come eco di pregiudizi culturali consolidati. Solo allora la vera giustizia, quella universale, troverà spazio nelle strade e nelle piazze del nostro tempo.
Altre Notizie della sezione

Giustizia e politica devono fermarsi, ricostruire fiducia e rispetto istituzionale.
30 Gennaio 2026Alla Cassazione appello corale: stop allo scontro, dialogo leale tra poteri per salvare indipendenza magistratura e credibilità democratica del Paese.

La democrazia è in evidente crisi
29 Gennaio 2026Sotto attacco al suo stesso interno perché ritenuta incapace di fornire risposte ai bisogni delle persone e soprattutto alle paure.

Referendum giustizia, una sfida riaperta?
28 Gennaio 2026Conoscere di più il quesito cambia gli equilibri: il No cresce, il Sì arretra, decisiva sarà la mobilitazione finale