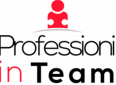Assicurazione professionale per avvocati: cosa copre davvero e come sceglierla con criterio
L’assicurazione di responsabilità civile professionale per gli avvocati incide direttamente sulla tranquillità con cui si esercita la professione.

L’assicurazione di responsabilità civile professionale per gli avvocati è spesso percepita come un adempimento formale, legato all’iscrizione all’albo e poco più. In realtà è uno strumento che incide direttamente sulla tranquillità con cui si esercita la professione, sulla tutela del patrimonio personale e sulla continuità dello studio in caso di errore.
Oggi la complessità delle pratiche, la pressione dei tempi (PCT, scadenze telematiche, udienze da remoto) e le aspettative dei clienti rendono il rischio di un inadempimento, anche minimo, tutt’altro che teorico. Per questo vale la pena guardare alla polizza non come a una “tassa”, ma come a un pezzo dell’organizzazione professionale.
Di seguito una panoramica ragionata dei principali aspetti da considerare, con qualche spunto pratico che raramente si trova nelle guide più sintetiche.
Il quadro normativo in sintesi
L’obbligo di copertura per gli avvocati discende, in particolare, dal D.P.R. 137/2012 e dalla normativa successiva che ha esteso l’obbligo assicurativo a tutti i professionisti ordinistici. L’idea di fondo è semplice: il cliente deve avere la ragionevole certezza che, in caso di errore del legale, esista un soggetto (la compagnia) in grado di risarcire il danno.
Nel concreto questo significa:
– la copertura deve essere attiva per tutta la durata dell’esercizio della professione;
– il massimale deve essere adeguato alla tipologia di incarichi svolti;
– occorre poter dimostrare, in caso di controlli, l’esistenza della polizza e delle sue principali condizioni.
Molti ordini territoriali, inoltre, hanno negoziato convenzioni collettive per garantire condizioni minime standard. Queste convenzioni non escludono la possibilità di polizze integrative individuali: anzi, per alcune fasce di rischio elevato (diritto societario complesso, operazioni straordinarie, consulenza fiscale strutturata) può essere quasi indispensabile affiancare una copertura aggiuntiva.
Il regime “claims made”: cosa significa davvero
Quasi tutte le polizze RC professionale per avvocati sono in forma “claims made”: viene assicurata la richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, anche se il fatto che ha originato il danno è avvenuto anni prima.
Per capire se si è davvero coperti, non basta guardare la data del sinistro, ma occorre incrociare:
– data del fatto (ad esempio, il termine processuale non rispettato);
– periodo di retroattività (da quanti anni prima la polizza copre fatti commessi);
– data della richiesta di risarcimento (quando il cliente formula la pretesa, anche tramite lettera del suo legale);
– eventuale periodo di ultrattività/postuma (la copertura “a coda” dopo la cessazione dell’attività).
Un punto spesso trascurato è la gestione delle “circostanze”: molte polizze richiedono di denunciare non solo le richieste formali di risarcimento, ma anche situazioni che potrebbero ragionevolmente sfociare in una richiesta futura (un grave disaccordo con il cliente, un evidente errore emerso, un provvedimento particolarmente sfavorevole). Segnalare tempestivamente una circostanza può fare la differenza tra un sinistro coperto e uno escluso anni dopo.
Retroattività e postuma: i momenti critici della carriera
Due fasi sono particolarmente delicate:
1 L’avvio dell’attività in proprio
- Un giovane avvocato che viene da anni di collaborazione in altri studi dovrebbe verificare se e come le attività svolte in passato siano coperte.
- In alcuni casi è opportuno farsi rilasciare dichiarazioni scritte sul fatto che lo studio precedente manterrà copertura per gli incarichi seguiti come collaboratore; in altri può essere utile una retroattività ampia sulla propria polizza individuale, chiarendo bene le attività svolte.
2 La cessazione o il passaggio di studio
- Un avvocato che va in pensione, entra in una STP o scioglie uno studio associato dovrebbe valutare attentamente una polizza postuma, spesso di durata pluriennale (5, 10 anni o più).
- In caso di scioglimento di studio associato, può essere prudente un accordo tra ex associati su chi mantiene o finanzia la copertura per i sinistri tardivi riferiti alle pratiche pregresse.
Questi aspetti raramente sono affrontati con anticipo, ma sono quelli che emergono con più forza quando si verifica un sinistro “fuori tempo massimo”.
Massimale, franchigia e struttura del rischio
Il massimale non è solo un numero da scrivere in proposta: è l’espressione del livello di responsabilità che lo studio si assume.
Tre profili sono particolarmente rilevanti:
– Massimale per sinistro e per anno: alcune polizze prevedono che il massimale sia “aggregato” per anno assicurativo. In caso di attività seriali (ad esempio, contenzioso di massa, recupero crediti, azioni ripetitive per molti clienti) il rischio è di consumare il massimale con pochi sinistri significativi, lasciando scoperti i successivi.
– Franchigia o scoperto: la franchigia fissa (es. 2.000 euro) pesa molto sui piccoli sinistri ma è più prevedibile; lo scoperto in percentuale è più delicato in caso di danni elevati. Va calibrato sulla reale capacità patrimoniale dello studio di “assorbire” l’esborso iniziale.
– Sottolimiti: attenzione ai sotto-massimali per alcune voci (violazioni privacy, perdita di documenti, responsabilità per collaboratori, attività specifiche come curatore, liquidatore, OCC). Un massimale principale elevato può essere accompagnato da sottolimiti molto bassi su rischi che, di fatto, sono quelli più attuali.
Un piccolo accorgimento organizzativo, spesso trascurato, è tenere traccia interna delle attività a più alto valore (ad esempio in un registro delle operazioni con valore economico superiore a una certa soglia) per avere una percezione realistica del massimale adeguato, anziché basarsi solo sul fatturato.
Cosa copre (e cosa non copre) la polizza
In linea generale, la RC professionale per avvocati copre i danni patrimoniali causati a terzi (clienti o, talvolta, controparti) per colpa professionale: errori, omissioni, negligenza, violazione di obblighi contrattuali nell’esercizio dell’attività forense.
Punti chiave da verificare:
– Definizione di “attività professionale”
Alcune polizze includono in automatico incarichi come:
- curatore fallimentare o liquidatore;
- gestore della crisi da sovraindebitamento;
- mediatore o arbitro;
- sindaco o componente di organi di controllo societari.
Altre richiedono un’esplicita estensione. È importante allineare la definizione di attività a ciò che realmente si fa, soprattutto negli studi che integrano consulenza legale e ruoli in organi societari.
– Collaboratori, praticanti, dipendenti
La copertura di solito si estende agli errori dei collaboratori, ma modalità e limiti variano. Conviene verificare:
- se i praticanti abilitati sono inclusi;
- se i coadiutori amministrativi che gestiscono scadenze e depositi telematici sono coperti per errori materiali;
- se esistono franchigie diverse per le attività delegate.
– Attività di tutela dati e strumenti digitali
Sempre più spesso il rischio professionale passa da:
- PEC non monitorate;
- malfunzionamenti del PCT o errori nei depositi telematici;
- gestione non corretta di documenti elettronici e firme digitali.
Alcune polizze considerano questi casi come normale colpa professionale; altre li spostano verso l’area “cyber”. Verificare bene questo punto è essenziale, soprattutto per gli studi che lavorano quasi esclusivamente in digitale.
Tra le principali esclusioni ricorrenti troviamo:
– atti dolosi o fraudolenti;
– sanzioni amministrative, fiscali o penali inflitte al cliente;
– danni puramente reputazionali non accompagnati da una perdita economica dimostrabile;
– responsabilità per attività non dichiarate o comunque estranee alla professione legale.
Studi associati, STP e responsabilità solidale
Gli studi associati e le STP pongono temi specifici:
– responsabilità solidale: un errore commesso da un singolo professionista può riflettersi sull’intero studio; la polizza deve coprire questa eventualità, chiarendo il rapporto tra singoli soci e soggetto “studio”;
– ripartizione dei massimali: è importante capire se il massimale è unico per tutti o “per testa”, e come questo incide sulla gestione di sinistri multipli;
– ingressi e uscite dei soci: chi entra in uno studio strutturato dovrebbe verificare non solo che esista una polizza, ma anche come sia disciplinata la copertura per gli incarichi pregressi e futuri; allo stesso modo, chi esce dovrebbe avere chiaro se continuerà ad essere coperto (e per quanto tempo) rispetto ai fascicoli gestiti in passato.
Una “chicca” poco considerata è la mappatura dei ruoli interni: associare formalmente a ogni pratica un “responsabile di incarico” e inserire questa informazione tra i dati utilizzati per valutare i rischi assicurativi permette, nel tempo, di negoziare condizioni più mirate, soprattutto per studi di dimensioni medio-grandi.
Compilare il questionario senza sottovalutare (né sovrastimare) il rischio
La fase di compilazione del questionario di rischio è spesso vissuta come una formalità, ma è uno dei passaggi più delicati: dichiarazioni incomplete o troppo ottimistiche possono essere utilizzate dalla compagnia per limitare la copertura in caso di sinistro.
Alcune buone pratiche:
– rileggere i dati di fatturato e distribuzione per aree di attività (civile, penale, tributario, societario, bancario, ecc.) non solo in base alla percezione, ma anche alle statistiche contabili;
– evidenziare con onestà la presenza di attività particolarmente rischiose (ad esempio, consulenza su operazioni straordinarie, piani di ristrutturazione complessi, tax planning aggressivo), spiegando però anche le misure di controllo interne adottate (doppia revisione, pareri collegiali, ecc.);
– indicare con precisione eventuali sinistri o circostanze pregresse, evitando di “nascondere” episodi minori: spesso è più rassicurante per l’assicuratore vedere un sinistro ben gestito che non vedere nulla.
Un accorgimento utile, poco diffuso, è redigere internamente un “profilo di rischio dello studio” da aggiornare ogni due anni: una scheda sintetica che descriva la composizione dello studio, le principali tipologie di incarico, i range di valore economico e le procedure interne di controllo. Questo documento può essere un supporto prezioso nelle trattative assicurative.
Gestione del sinistro: cosa fare (e cosa evitare)
Quando si verifica un potenziale errore, la tentazione naturale è “aspettare e vedere”. Dal punto di vista assicurativo, è spesso la scelta peggiore.
In generale, è prudente:
– informare la compagnia (o il broker) al primo segnale concreto di contestazione, anche informale;
– evitare di assumere impegni di risarcimento o di riconoscere per iscritto la propria responsabilità senza essersi coordinati con l’assicuratore;
– conservare con cura tutta la documentazione (email, PEC, note interne, bozze) relativa alla pratica;
– redigere una cronologia sintetica dei fatti, utile sia per la compagnia sia per la successiva gestione difensiva.
Una buona polizza non si limita a rimborsare il danno, ma copre anche le spese di resistenza, cioè i costi per difendersi dalla pretesa del cliente. Verificare come e fino a che limite queste spese siano garantite è un aspetto non secondario.
Polizze collettive, individuali e strumenti online
Molti avvocati oggi si trovano a gestire un mix di coperture:
– la polizza collettiva o convenzionata dall’ordine, che garantisce una base minima uniforme;
– una o più polizze individuali integrative, spesso con massimali più alti o con estensioni specifiche legate al proprio settore di attività.
In questo contesto, la cosa importante è evitare sovrapposizioni inconsapevoli e, al contrario, colmare i vuoti: la presenza di due polizze non sempre significa il doppio di tutela, se entrambe escludono la stessa tipologia di rischio.
Per orientarsi tra offerte e condizioni, è possibile utilizzare anche piattaforme di confronto online che permettono di richiedere preventivi da diversi intermediari e compagnie; a questo proposito, ad esempio, si può consultare la pagina dedicata all’assicurazione professionale avvocato.
Un approccio maturo alla copertura assicurativa
In definitiva, l’assicurazione professionale dell’avvocato non è solo un obbligo di legge, ma un tassello della governance dello studio:
– tutela il patrimonio personale e quello dello studio;
protegge la continuità dei rapporti con la clientela;
– incentiva l’adozione di procedure interne più ordinate (checklist, doppie verifiche, tracciamento delle scadenze).
Rivedere periodicamente la polizza, alla luce dell’evoluzione della propria attività, dei cambiamenti normativi e dell’organizzazione interna dello studio, è un esercizio di gestione del rischio che può aiutare il professionista non solo ad essere “in regola”, ma a lavorare con maggiore serenità.
Altre Notizie della sezione

Cancellazione avvocati: la Consulta dichiara illegittimo divieto in pendenza disciplinare
14 Gennaio 2026La Corte costituzionale dichiara illegittimo art. 57 legge 247/2012 e art. 17 comma 16: divieto cancellazione avvocati durante procedimento disciplinare violava libertà di lavoro e autodeterminazione professionale.

Arriva la nuova app dell’ordine degli Avvocati di Milano
13 Gennaio 2026Disponibile sugli store dal 26 gennaio 2026!L’Ordine degli Avvocati di Milano è lieto di annunciare il lancio della nuova versione della propria App ufficiale, disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android a partire dal 26 gennaio 2026.Un app completamente rinnovata, non solo nell'aspetto, pensata per offrire un’esperienza d’uso più completa, moderna e funzionale. Grazie alla collaborazione con Lefebvre Giuffrè, la nuova App integra anche strumenti e contenuti di valore pensati per facilitare l’attività quotidiana dell’avvocato, potenziando anche l’accesso agli aggiornamenti e al patrimonio documentale dell’Ordine.Un nuovo modo per restare connessi e informati su quello che accade nel mondo legale milanese.

Avvocati Ancona, meno iscritti all’ordine ma ci sono più donne.
13 Gennaio 2026Il presidente Marasca: “Garantita assistenza a tutti”.