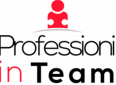LIBERI PROFESSIONISTI: ALLARME PREVIDENZA
Cresce la pressione sui bilanci e sulle regole interne
In evidenza
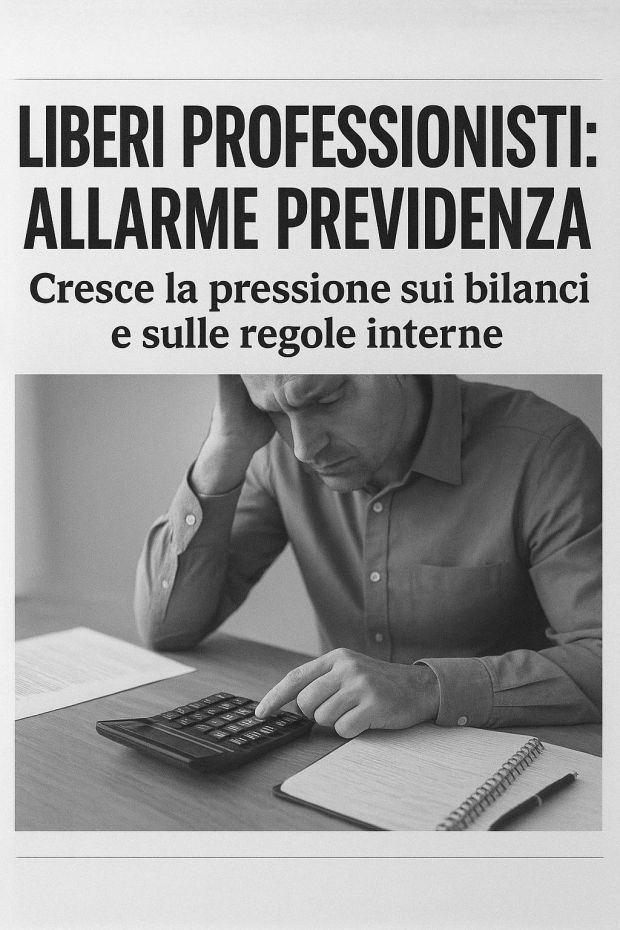
La privatizzazione degli Enti di previdenza ed assistenza dei liberi professionisti nasce da alcune norme di delega contenute nella legge 537/1993 con le quali l’allora Governo Ciampi si proponeva, inter alia, di attuare un riordino degli istituti previdenziali e assistenziali in essere. Nei primi anni novanta, infatti, il Governo Ciampi con l’allora Ministro della Funzione Pubblica, Sabino Cassese, avviò un importante processo di riforma della Pubblica Amministrazione con interventi normativi che riguardavano l’intero sistema delle amministrazioni centrali, tra cui gli enti pubblici. La riforma interessò ampiamente il settore degli enti pubblici, prevedendo che alcuni enti fossero soppressi, altri istituiti, mentre altri, come gli enti previdenziali appunto, venissero riordinati tramite la privatizzazione.
La Legge n. 335 del 1995 (cd. Riforma Dini) ha, probabilmente in modo non lungimirante, introdotto una netta distinzione tra lavoratori dipendenti e alcune categorie di autonomi iscritti all’INPS e alla GS, da un lato, e i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza, dall’altro.
Le Casse sono così uscite dal sistema pubblico, per intraprendere un percorso autonomo, trasformandosi in Enti di diritto privato (d.lgs. 509/1994).
La disciplina in tema di trattamenti erogati dalle gestioni di forme obbligatorie di previdenza e assistenza deve fondarsi su tre capisaldi: sostenibilità, equità – tra generazioni e tra individui della stessa generazione – e adeguatezza intesa come capacità di fornire prestazioni previdenziali idonee al sostentamento del pensionato.
Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del d.lgs. 509/1994, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Le Casse di previdenza sono 20 distinte tra quelle del 509/1994 e quelle del 103/1996.
Le Casse privatizzate del 509/1994 sono caratterizzate da un sistema misto in cui il sistema a ripartizione PAYG è integrato da una componente Funded accumulata in fase iniziale grazie ad una situazione molto favorevole nel rapporto tra attivi e pensionati.
Pertanto, di fatto le Casse operano in un sistema di finanziamento misto con componente sia a ripartizione che a capitalizzazione: la loro sostenibilità dunque dovrà essere supportata da un mix sia della componente demografica (in termini di attrattività prospettica della professione e dei conseguenti futuri ingressi) sia da una oculata e prudente gestione degli investimenti del patrimonio legati alla componente Funded.
Il passo successivo è stata la costituzione di nuovi Enti di previdenza privati per assicurare la copertura a categorie di professionisti non ancora soggette a tutela previdenziale (d.lgs. 103/1996).
Gli Enti 103 sono un unicum nel panorama previdenziale italiano.
Adottano infatti il metodo contributivo del sistema pubblico di 1° pilastro per il calcolo delle pensioni, ma se ne differenziano perché il regime di finanziamento è a capitalizzazione, a differenza di Inps che è finanziato a ripartizione e le Casse del 509/ 1994 che si basano su un mix di ripartizione e capitalizzazione collettiva.
La differenza nei regimi di finanziamento si coglie anche nei bilanci di esercizio degli Enti 103: tra le passività, infatti, viene data evidenza dei montanti contributivi che rappresentano il “debito” verso gli iscritti e i pensionati.
Pur essendo a capitalizzazione, gli Enti 103 devono, per legge, adottare il PIL per la rivalutazione dei montanti contributivi individuali al posto, come sarebbe logico, del rendimento del patrimonio investito che rappresenterebbe il loro tasso di “equilibrio”. Alcuni Enti riconoscono una rivalutazione aggiuntiva dei montanti qualora il rendimento del patrimonio investito sia superiore alla rivalutazione del montante in base al PIL (cd. extra-rendimento); il meccanismo passa attraverso la costituzione di un Fondo di riserva nel quale viene accantonato l’extra-rendimento per la successiva destinazione a montante.
Fondamentale per la valutazione dell’adeguatezza delle prestazioni è il sistema di calcolo delle pensioni. Così come per i lavoratori iscritti all’Ago, anche le Casse di previdenza avevano in passato sistemi di calcolo maggiormente ispirati a modelli reddituali come il retributivo, che offrivano pensioni più generose. In seguito, la necessità di riportare un equilibrio di lungo periodo, ha portato molte Casse di previdenza dapprima a rivedere i parametri al fine di ridurre la copertura, per poi optare per un sistema contributivo, introdotto pro-rata. Le Casse istituite a norma del d.lgs. 103/96, inoltre, sono nate fin dall’inizio con l’obbligo di utilizzare il metodo contributivo.
Tale sistema rende più semplice mantenere un equilibrio per l’ente previdenziale, ma è fortemente influenzato dalla stabilità della carriera lavorativa e dal livello contributivo. Redditi altalenanti con possibili buchi contributivi potrebbero ridurre di molto la copertura previdenziale. Si consideri inoltre che i livelli contributivi base dei liberi professionisti vanno dal 10 al 22%. Immaginando un contributo soggettivo del 10% annuo per quarant’anni, è improbabile che si possano raggiungere rendite pensionistiche superiori al 22-27% dell’ultimo reddito. Laddove la pensione fosse l’unica entrata del lavoratore, ciò comporterebbe un abbassamento drastico del tenore di vita.
Con la privatizzazione e la rinuncia alla garanzia statale, le Casse si sono però assunte anche il debito latente sin lì maturato.
Le Casse di previdenza, come ricordato più sopra, sono 20, cui fanno capo 22 gestioni.
Gli iscritti al 31.12.2024 erano 1.849.219.
Il patrimonio si è evoluto dai 37,60 miliardi del 2007 ai 115,23 miliardi del 2024.
Anche le Casse di previdenza sono state interessate da quel processo di “ripubblicizzazione” che ha riguardato tutti i soggetti che hanno avuto un forte grado di autonomia e ai quali il legislatore ha delegato delle funzioni o attività pubbliche a partire dagli anni ’90. È iniziato, insomma, un percorso inverso rispetto a quello di “privatizzazione” promosso dal legislatore agli inizi degli anni 90 che ha portato ad introdurre una serie di controlli formali per cui i soggetti “ripubblicizzati”, fra i quali le Casse, si sono trovati investiti da una serie di vincoli, rispetto alle origini.
Durante la trentennale gestione vi sono state anche delle criticità di gestione, sia per mala gestio che per “i cigni neri” del mercato finanziario.
Come evidenziato anche dal recente report della Commissione Bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali, vi è nelle Casse di Previdenza la necessità di implementare la competenza e professionalità specifica in materia finanziaria.
Le Casse, in rapida sintesi sono tenute a:
- garantire una gestione efficiente del patrimonio;
- assicurare prestazioni adeguate agli iscritti;
- mantenere la sostenibilità di lungo periodo, attraverso la patrimonializzazione rispetto al debito latente (funding ratio);
- sviluppare politiche di welfare mirate.
Emerge anche una nuova categoria, quella dei soggetti “deboli”, dove alla “debolezza”, anche di genere, occorre porre rimedio attraverso l’effettivo esercizio dei diritti, che postula non più solo una mera redistribuzione di beni, ma soprattutto interventi “positivi” tesi alla diffusione delle opportunità che, a sua volta, significa non solo “protezione” ma “promozione” di diritti.
Il sistema previdenziale dei liberi professionisti deve però affrontare sfide cruciali che sono:
– transizione demografica
– evoluzione del mercato del lavoro;
– necessità di tutele crescenti;
– complessità normativa.
Con la crisi demografica in atto, tra non molti anni, il rapporto iscritti v pensionati sarà di 1 a 1 il che significa che le Casse andranno incontro a saldi previdenziali negativi con la necessità, per poter pagare le pensioni, di utilizzare prima il rendimento del patrimonio e poi il patrimonio stesso.
Questa situazione spinge i management ad alzare il livello di rischio nella gestione del patrimonio per cercare di conseguire un rendimento maggiore. Sino ad oggi senza regole cogenti in materia di investimenti, che si attendono sin dal 2011.
La natura previdenziale della provvista mal si concilia con la volatilità dei mercati finanziari, perché le pensioni, in base all’art. 38 della nostra Carta costituzionale, non possono dipendere dall’andamento dei mercati finanziari, senza la garanzia finale dello Stato, alla quale le Casse hanno volontariamente rinunciato.
Per contro le Casse del 103/1996, che sin dalla loro origine nascono finanziate dal sistema a capitalizzazione collettiva, oltre a denunciare i rischi finanziari di cui sopra, hanno un problema, non tanto di sostenibilità del sistema, ma di adeguatezza delle prestazioni.
Un Legislatore previdenziale lungimirante, a fronte di siffatte criticità, che nel tempo possono costituire una “bomba sociale”, dovrebbe per tempo por mano ad una riforma di sistema che potrebbe essere l’accorpamento in una unica Cassa per tutti i professionisti, sul presupposto innegabile che – a prescindere dalle singole specificità – la previdenza dovrebbe avere le stesse regole e essere uguale per tutti, al fine di realizzare importanti economie di scala, oppure rientrare nel pubblico il che, consentirebbe, di risolvere anche il problema della doppia contribuzione per medici e farmacisti dipendenti e l’annoso problema dei “contributi silenti” che caratterizzano la gestione Enasarco.
Già nel 2010 la prof. Elsa Fornero nel suo “Una questione irrisolta. Le Casse Previdenziali dei Liberi Professionisti”, AREL Europa lavoro economia, n.3, 2010 ammoniva: “Il loro futuro non interessa soltanto gli iscritti (poco meno di due milioni tra attivi e pensionati), ma tutti gli italiani, i quali potrebbero essere chiamati, come contribuenti, a rimediare alle scelte non sempre lungimiranti del legislatore e di chi amministra le Casse. Nella previdenza privata, infatti, non meno che in quella pubblica, le valutazioni si fanno guardando al lungo periodo e il futuro delle Casse, a dispetto di risultati gestionali di breve termine generalmente buoni, mostra problemi di sostenibilità dovuti in larga misura a difetti nel disegno istitutivo”.
Secondo la IA: “Le principali criticità delle casse di previdenza dei professionisti riguardano la gestione patrimoniale e dei rischi, la scarsa trasparenza, i ritardi normativi, l’ambiguità tra natura pubblica e privata, e l’inefficacia di alcuni strumenti di welfare, come i bandi, che non sempre premiano chi ne avrebbe più bisogno”.
Se non ora, quando?
Che il comparto delle Casse di Previdenza abbia bisogno di un ripensamento, risulta anche da quando verrò ora raccontando.
Giovedì 23 ottobre u.s. il Presidente della Commissione bicamerale di controllo ha messo in discussione il bilancio tecnico delle Casse di previdenza affermando che “Quello relativo ai bilanci tecnici delle Casse di previdenza – introdotto dalla riforma dell’ex ministro Elsa Fornero – è un tema che in Commissione vorremo affrontare. Nel caso della Cassa dei geometri, il bilancio tecnico del 2012 ha commesso, rispetto ai dieci anni successivi, un errore di circa il 25% sulla platea degli iscritti. Una previsione del genere a cosa serve? Probabilmente si tratta di uno strumento inadeguato e si rende necessario un intervento legislativo”. (Fonte: ANSA, 24.10.2025)
Per contro, proprio il MEFOP sostiene che “In qualsiasi settore di attività la visione strategica assume un ruolo cruciale per la sostenibilità dell’organizzazione. La visione nel lungo periodo degli obiettivi, degli impegni necessari a raggiungerli e delle obbligazioni nei confronti degli stakeholder deve guidare tutto il percorso che l’ente dovrà impostare e seguire nel tempo. Tale ruolo è ancora più importante nel settore del welfare privato, dove a motivazioni “aziendali” si aggiungono anche stringenti obblighi normativi. Una risposta rigorosa a tale necessità è fornita da uno strumento di analisi fondamentale e complesso: il bilancio tecnico. La sua funzione può essere assimilata a quella di un sistema di navigazione avanzato che, a differenza di una semplice mappa, elabora proiezioni dinamiche basate su molteplici variabili. L’elaborazione di tale documento richiede una solida base di conoscenze, analogamente a come l’ingegneria civile è indispensabile per la costruzione di grandi opere. Pertanto, ogni valutazione si fonda sui principi cardine della matematica finanziaria e attuariale, quali il valore attuale, il calcolo delle probabilità e la teoria delle rendite. La padronanza di questi concetti è un prerequisito essenziale per comprendere e validare la robustezza dell’intera architettura valutativa. Un esame approfondito della struttura del bilancio tecnico, sia nella sua componente analitica che in quella sintetica, permette di comprendere il processo attraverso cui le proiezioni a lungo termine vengono tradotte in indicatori quantitativi di sostenibilità. Tale processo è finalizzato a governare il delicato equilibrio tra le attività e le passività dell’ente, secondo i principi dell’Asset Liability Management (ALM) interpretati in una prospettiva attuariale. Il punto di partenza di una valutazione adeguata degli impegni è la definizione delle ipotesi sottostanti, come la selezione delle basi tecniche, sia demografiche (relative all’evoluzione dei tassi di mortalità e longevità) sia economico-finanziarie (come il tasso di sconto e il tasso di inflazione atteso). Data l’intrinseca incertezza che caratterizza gli scenari futuri, è necessario procedere oltre la semplice definizione di un’ipotesi centrale. L’applicazione di analisi di sensitività e di stress test diventa quindi indispensabile. Queste tecniche non rappresentano meri adempimenti formali, ma simulazioni di scenari avversi volte a misurare la resilienza del sistema e a preparare l’ente ad affrontare potenziali shock esogeni. I principi e le metodologie descritti trovano applicazione in diversi contesti. Un ambito di elezione è rappresentato dalle casse di previdenza per i liberi professionisti, per le quali il bilancio tecnico costituisce lo strumento cardine per la verifica della sostenibilità di lungo periodo. Analogamente, nell’ambito dei fondi pensione, l’applicazione di tali principi implica la conformità a normative di riferimento, quale la direttiva IORP II, e una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità attribuite alla Funzione Attuariale. Anche nei fondi sanitari integrativi, in particolare quelli che hanno optato per una ritenzione del rischio, il bilancio tecnico costituisce un presidio imprescindibile di corretta gestione e di sostenibilità, allo scopo di valutare in maniera prospettica la capacità dell’ente di far fronte agli impegni assunti nei confronti degli iscritti”. (Fonte: Bilancio tecnico, un navigatore per il lungo periodo, Maria Dilorenzo / Luca Di Gialleonardo, 06 ottobre 2025)
Basare le analisi di sostenibilità sull’equilibrio tra entrate e uscite su stime a 50 anni, in base all’art. 24 della legge 214/211, è un compito delicato da un punto di vista statistico, nonché gestionale, ma serve a garantire la sostenibilità dell’Ente in cui l’iscritto è obbligato, per legge, ad iscriversi, avendo davanti a sé un percorso lavorativo di almeno 30 anni e una sopravvivenza, al pensionamento, di altri 20 anni, e 30 +20 da appunto 50.
Le difficoltà che hanno indotto il Legislatore ad intervenire con la legge di Bilancio 2021, (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi 103 e 104) procedendo con la confluenza del fondo sostitutivo di INPGI/1 in INPS, come soluzione per la situazione di grave crisi del fondo accollando al bilancio pubblico la copertura dei disavanzi che si erano generati, dimostra come la sostenibilità di fondi previdenziali che si basano su una sola categoria professionale possa essere oggetto di instabilità tali da imporre l’intervento pubblico al fine di garantire la corretta applicazione dell’art. 38 della Costituzione.
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli Enti previdenziali, nell’audizione del 30.11.2023 dinanzi alla Bicamerale di controllo sugli enti previdenziali ha così concluso: “Degli aspetti afferenti al delicato settore degli investimenti patrimoniali delle Cassa già si è, in altra parte di questo documento, diffusamente detto e vale qui soltanto sottolineare come, a giudizio della Corte, resti importante che in tempi quanto più possibile contenuti trovi attuazione quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2023 e che, quindi, siano definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Covip, le norme di indirizzo degli Enti previdenziali in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Ciò al fine di permettere, entro sei mesi dall’adozione di tale decreto e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, agli Enti l’adozione di nuovi regolamenti. Vale, comunque, ribadire come la Corte – a prescindere da quelli che sono i compiti istituzionali affidati alla Covip (delle cui relazioni sarebbe auspicabile fosse destinataria in via formale anche la Corte dei conti) – nei propri referti ha sempre invitato a ricercare strumenti finanziari che, nel rispetto degli interessi pubblici perseguiti, siano improntati alla massima prudenza. Le Casse, infatti, è d’uopo ricordarlo, sono chiamate a garantire sempre la finalità originaria alla base del processo di privatizzazione – riconoscere corpi intermedi in grado di garantire la funzione pubblica di protezione sociale – senza mai perdere di vista il loro obiettivo ultimo, ovvero la garanzia e la tutela dei liberi professionisti iscritti che “hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”, in ossequio all’articolo 38 della Costituzione. Tuttavia, più volte, le differenti Relazioni della Corte hanno segnalato una non prudente gestione degli investimenti immobiliari e mobiliari, che ha comportato un rendimento derivato negativo. Sono peraltro emerse alcune problematiche di carattere strutturale all’interno degli Enti quali una sovrapposizione di organi, una loro composizione molto ampia (con un relativo aumento del costo) e, talvolta, carenze di professionalità specifiche. Un cenno occorre riservare alle politiche poste in atto dalle Casse nella raccolta dei contributi obbligatori versati dagli associati e, in particolare, in tema di recupero dei crediti di questa natura. Dal controllo della Corte è emersa talvolta una gestione del recupero dei crediti disomogenea, con effetti non di rado divergenti. Al riguardo, occorre guardare con favore all’adozione di misure incisive volte alla riscossione di tali poste creditorie, spesso ingenti per entità e per numero di debitori, anche al fine di evitare rischi di prescrizione. Alcune Casse, a tal riguardo, hanno positivamente sperimentato forme coattive di recupero, ma anche efficaci piani di rateizzazione. A margine di tale disamina, in conclusione, si riassumono i temi più rilevanti su cui la Corte dei conti nei propri referti al Parlamento ha avuto l’occasione di segnalare l’attenzione:
– l’efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione dei vertici che, talvolta, prevedono l’erogazione di compensi ad organismi pletorici o di scarsa utilizzazione o per la partecipazione a comitati consultivi di varia natura;
– l’introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità, di criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli Enti previdenziali;
– la razionalizzazione degli assetti di vigilanza;
– i rischi connessi all’aumento, riscontrato in molti casi, del valore dei crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti;
– l’adeguatezza dei fondi rischi rispetto sia all’incertezza di alcuni rendimenti finanziari sia rispetto ai procedimenti legali in corso;
– l’eventualità di un incremento delle prestazioni di welfare erogate dagli Enti a favore degli iscritti;
– l’adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali.”
Queste le conclusioni della Commissione parlamentare di controllo sugli Enti previdenziali del 12 giugno 2025:
“2.5 Conclusioni sulle Casse di previdenza
Le evidenze emerse nel corso dell’indagine supportano l’ipotesi che esistano margini di miglioramento delle soluzioni organizzativo-procedurali adottate dalle Casse nonché delle loro attività di investimento, anche al fine di perseguire il miglior interesse degli iscritti.
In alcuni casi potrebbero essere adottate procedure più adeguate, anche a legislazione vigente; in altri casi, invece, potrebbe risultare necessario un intervento normativo. Qui di seguito – senza la pretesa di prefigurare una lista completa di soluzioni definitive – si indicano le principali aree di possibile intervento.
Mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati. In particolare, l’appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l’assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l’efficace espletamento dell’incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Sembrerebbe, pertanto, opportuno introdurre regole più chiare e stringenti, prevedendo un necessario «bilanciamento» tra vincoli alle politiche di investimento delle Casse (si è in attesa dal 2012 del decreto MEF sugli investimenti) e l’adeguatezza della corporate governance degli Enti. La frammentazione esistente fra le diverse strutture di governo societario e gli eterogenei regimi contributivi andrebbe ridotta, e per rendere più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali e anche per favorire possibili forme di aggregazione.
Dall’analisi delle strutture organizzative, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti, emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell’Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale). In termini di Asset Under Management (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato – emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari in media a circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili di attenzione circa l’effettiva capacità dell’Ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti.
Nell’attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli advisor. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia dall’indagine è emersa una certa omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l’assenza (cfr. grafici a pag. 54 e 55) di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi previdenziali e assistenziali (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione, sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la «robustezza» delle procedure secondo le quali le Casse interagiscono con gli advisor, al fine di gestire il rischio di eccessivo «affidamento».
Dall’analisi dell’informativa contabile delle Casse emergono significativi profili di attenzione sulle seguenti aree:
- i) gestione del portafoglio immobiliare (bassa redditività) e crediti verso inquilini (morosità);
- ii) crediti contributivi nei confronti degli iscritti (stock significativo), meccanismi di recupero e mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti;
iii) spese sostenute per il contenzioso (rischio di antieconomicità del giudizio promosso);
- iv) componenti di costo degli strumenti finanziari acquistati. In materia, si dovrebbe semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli attualmente in essere al fine di armonizzare la vigilanza ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.
Dall’indagine è emersa la presenza di OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un asset manager (controllato al 100 per cento) all’interno di una Cassa. Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali intermediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del management e alla gestione di possibili conflitti di interesse. Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi.
Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, si registrano «ritardi» di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni effettuate e le proiezioni contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un gap temporale di circa quattro anni rispetto all’effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (per ogni categoria di riferimento). Sarebbe necessario ridurre tale gap temporale e incentivare la predisposizione di Bilanci tecnici specifici (oltre che standard). Documenti, quest’ultimi, fondamentali per definire l’ALM, da cui poi discendono l’AAS e l’AAT.
Gli investimenti in OICVM nonché in OICR Alternativi sono realizzati in maniera molto significativa attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero. Occorre riflettere sia sulle «effettive» differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali sia sulla «capacità» dell’industria dell’asset management nazionale di far fronte e assistere le esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.
Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli Enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione che certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994). In materia, sarebbe opportuno estendere agli enti di previdenza l’applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di «revisione legale» in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore.
In conclusione, la sostenibilità di lungo termine delle Casse previdenziali dipende da una pluralità di fattori, riconducibili essenzialmente all’andamento del saldo della gestione (somma dei saldi di previdenza e di assistenza) e al rendimento del patrimonio accumulato.
Sull’andamento della gestione previdenziale, espresso dal saldo per contributi e prestazioni, incidono i regimi contributivi e prestazionali, oltre che le caratteristiche reddituali e socio-demografiche dei diversi bacini di riferimento delle Casse di previdenza. Per quanto riguarda, invece, la redditività degli investimenti, particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché gli adeguati sistemi di corporate governance. In materia, occorrerebbe quindi rafforzare le forme di controllo e sulle modifiche degli statuti e dei regolamenti e sul profilo rischio-rendimento degli investimenti effettuati.
Concludendo, l’auspicio è che la presente Relazione risulti utile a stimolare il dibattito del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni, anche per promuovere le opportune o necessarie iniziative di carattere normativo.”
Altre Notizie della sezione

SUBITO I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI BILANCIO
30 Gennaio 2026I Consulenti del Lavoro sollecitano Mef e Agenzia Entrate: servono istruzioni per applicare le novità della Legge di Bilancio 2026.

NASCE LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DEI NOTAI LOMBARDI
29 Gennaio 2026Con Mascellaro nasce organismo che promuove equità, inclusione e cultura professionale condivisa nei distretti notarili lombardi di tutta la regione.

ANTISEMITISMO, IL TESTO BASE DEBUTTA AL SENATO
28 Gennaio 2026Nella Giornata della Memoria la Commissione Affari costituzionali adotta il ddl del leghista Massimiliano Romeo. Si apre la fase degli emendamenti, tra appelli all’unità e divisioni trasversali sul saluto romano. Segre chiede “ampia convergenza”, La Russa punta all’Aula a marzo.